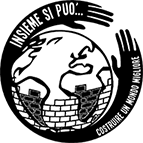Il viaggio non finisce mai…
Un viaggio… Non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati” (Ryszard Kapuscinski)
Ringrazio “Insieme si può…” per avermi dato l’opportunità e il piacere di ripensare ai miei viaggi. I luoghi restano sullo sfondo della memoria, il tempo sfuma, ma gli incontri, anche fugaci, restano. Racconterò di donne che ho conosciuto, di altre che ho solo intravisto, la cui storia, però, traspariva dai volti, dagli sguardi e dai gesti.
Vorrei poter esprimere la felicità delle ragazze di Ruhengeri (Ruanda) che, terminato il corso di sartoria, si caricavano sul capo, come un trofeo, la macchina da cucire finalmente conquistata e si recavano alle loro case sognando una vita migliore.
Progetti di vita anche nel cuore delle mamme cercatrici d’oro nella miniera di Bettaroya, in Camerun. Il sole cocente sulla schiena, le gambe immerse nel fango, scuotevano abilmente il setaccio nella speranza che un piccolo frammento prezioso vi fosse rimasto sospeso. Hanno alzato per un attimo il capo verso di noi, gli occhi rassegnati e stanchi, mentre bimbi più piccoli stavano seduti, silenziosi e guardati a vista da fratelli e sorelle più grandi. Mi sono vergognata di essere stata lì, come una spettatrice allo zoo.
Vita ormai segnata, invece, quella delle due donne anziane che ho visto salire faticosamente sulla ripida strada che da Massaua porta ad Asmara (Eritrea). Mi sembra di rivedere le loro spalle ricurve e il volto quasi nascosto sotto i rami secchi raccolti nella scarpata: non povere vecchie, ma persone che con dignità si stavano caricando il peso della vita quotidiana.
Ma ho incontrato anche donne per cui l’unica fatica fisica consisteva nel tenere la penna in mano, credo che il peso di una zappa sarebbe stato più lieve. Le ricordo ad Ariwara, Congo, sedute sui gradini della scuola in attesa dell’esame. Non più giovanissime, qualcuna anzi era stata portata in bicicletta dal figlio, ripassavano le tabelline o leggevano sillabando piccoli testi. Questa fatica le avrebbe rese meno dipendenti dai mariti, e avrebbe loro permesso di gestire autonomamente i loro piccoli commerci.
Ora tre storie di tre grandi donne.
Suor Silvia Gallina: un monumento, per il fisico imponente e il cuore immenso. La chiamavano Madre Teresa del Bangladesh, Paese a cui ha dedicato 45 anni della sua vita di missionaria delle Suore di Maria Bambina. La ricordo con la sua borsa di tela a tracolla, sempre aperta, pronta a donare parole, sorrisi, ma anche rimbrotti a chi la fermava per strada o la cercava alla missione. Si rivolgevano a lei cristiani (1%), musulmani, indù. A tutti suor Silvia prestava attenzione ed aiuto.
Annessa alla missione c’era la scuola primaria. Alla mattina arrivavano bambini e ragazzi, belli, con le divise pulite, le scarpe, la cartella in spalla. Dopo l’alzabandiera e il canto dell’inno nazionale salivano alle loro classi. All’uscita li attendevano qualche automobile e tanti risciò.
Al pomeriggio, però, i cancelli della scuola si aprivano per far entrare ragazzi scalzi, vestiti sommariamente, i capelli arruffati; salivano le scale, entravano nelle stesse aule e seguivano le stesse lezioni dei loro coetanei del mattino. Un giorno, mentre li guardavo dalla finestra, suor Silvia semplicemente mi ha detto: “Li vedi? Sono i ragazzi che vivono per strada, vendono limoni al mercato, trasportano persone sui risciò o lavorano nei laboratori artigianali… Io li ho invitatati alla scuola negoziando con le famiglie e i datori di lavoro e “ricattando”, ma a fin di bene, anche qualche papà che mi chiedeva di poter iscrivere il figlio qui; in cambio, chiedevo la scuola del pomeriggio per il bambino alle sue dipendenze”.
Poi, ammiccando, aggiungeva: “I figli dei ricchi che frequentano la mattina, pagano anche per i più poveri”. Suor Silvia ci ha lasciati nel maggio 2002.
Il ricordo di suor Silvia mi richiama alla mente un’altra amica, suor Mariangela D’Incà, canossiana, originaria di Castion, dolce d energica. Nino ed io l’abbiamo incontrata a Bunia, in Congo. Ci ha accolto con le sue due consorelle ed una decina di ragazzi dai volti vissuti e gli occhi furbi. Erano i ragazzi di strada che le suore incontravano al mercato o alle pompe di benzina dove sniffavano vapori e che avevano deciso di accogliere nella loro casa in attesa di trovare le famiglie. Consapevoli del loro difficile e, forse, anche pericoloso compito, si sono fatte esse stesse famiglia.
Concludo con la storia, piccola ma significativa, di Teresona, ospite da sempre all’orfanotrofio di Kiwanga. E proprio lì l’ho incontrata, giovane donna con la mente di bambina. Attirava l’attenzione di tutti quando vedeva passare un aereo e gridava: “Uncle George, uncle George!”. Un pomeriggio un’assistente è arrivata alla casa con un fardello in braccio: era Maria, una bambina visibilmente disabile. Subito Teresona si è agitata, ha iniziato a fare gesti con le mani portandosele al petto e farfugliando parole che potevano significare “mia, mia”, ha preso Maria, l’ha fatta coricare in un lettino e l’ha sorvegliata fino a sera. Ho pensato più volte a quel gesto materno e mi chiedo ancora: “È stato istinto o empatia verso un esserino che aveva bisogno come lei di cure e affetto?”. Certamente, un gesto di vera accoglienza.
Maria Teresa Vedana – Gruppo ISP Gron-Sospirolo