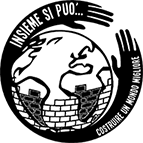Il dono di poter viaggiare
Monica Zaghet è una cooperante da oltre 20 anni, specializzata in crimini di guerra, questioni di genere, minori, migrazioni, traffico di esseri umani, peace building e peacekeeping, per ONG, aziende, Think Tank, Tribunali e altre istituzioni nazionali e internazionali. Volontaria di Insieme si può e del Gruppo ISP di Porcia (PN), è referente del progetto legato all’emergenza Covid in India raccontato qui.
Le chiediamo di parlare un po’ del viaggio, dimensione fondamentale del suo lavoro e della sua vita.
Monica, hai fatto molti viaggi e per disparati motivi: cosa rappresenta il viaggio per te?
Semplicemente il viaggio è parte integrante della mia vita, è stato così fin da piccola. È la mia stessa natura che mi porta a conoscere, a scoprire, con un approccio relativista, le realtà che mi accolgono. Mi piace essere un’ospite silenziosa, cerco di rispettare e comprendere la sensibilità del luogo.
Il viaggio è una dimensione che è cresciuta insieme a me, in parallelo con le vicissitudini che hanno attraversato la mia vita. Mentre studiavo, volevo andare sul campo a conoscere, comprendere, sentire… Poter viaggiare è un grande dono, è un processo di evoluzione, mi fa sentire parte di dinamiche universali.
Quali i viaggi o i luoghi più significativi?
Sicuramente l’India, a cui mi sono avvicinata grazie alla passione per l’Oriente e la sua storia e cultura, amore assoluto che mi ha sostenuto nell’impegno come cooperante.
In particolare, in questo momento mi sento di parlare di Bangalore, la Silicon Valley indiana, dove realtà opposte stridono e allo stesso tempo convivono. Accanto ai grattacieli, c’è la quotidianità dello slum, in un contrasto incredibile, nel senso etimologico di questa parola. La maggior parte degli abitanti dello slum di Koramangala lavora a chiamata nell’indotto della parte ricca della città, in edilizia, nei servizi, nella ristorazione; con la pandemia e le conseguenti restrizioni hanno perso la loro fonte di reddito da un giorno all’altro. Proprio nello slum di Bangalore stiamo portando i respiratori d’ossigeno, gli ossimetri e i termometri del progetto con ISP: questo bisogno è emerso parlando con l’associazione Swabhimaan, impegnata quotidianamente da anni in questo contesto.
Poi c’è il Congo, con cui ho un legame anche familiare perché un membro della mia famiglia, ex primario di pneumologia, che ho ammirato tantissimo fin da bambina, ha fondato lì una ONG e un ospedale, offrendo cure mediche gratuite a migliaia di pazienti. Mi sono sempre interessata alla situazione congolese, dal punto di vista antropologico, storico, legale, umanitario e ho cercato per quanto possibile di portare il mio contributo in un luogo tanto complesso, quanto raramente trattato con verità e giustizia dalla stampa nazionale e internazionale. Il Congo è uno dei Paesi più belli del mondo, ma anche uno dei luoghi dove l’essere umano sta manifestando alcuni dei suoi aspetti peggiori, lo sfruttamento delle miniere di coltan per citarne uno.
Un luogo caro all’anima è riservato al Kurdistan, che mi ha visto coinvolta a livello umanitario e politico. Ho un amore profondo verso questi territori, le persone, la cultura, gli idiomi stessi. Resto legatissima a questa terra violata e bistrattata nel corso dei secoli, la cui popolazione lotta da anni contro soprusi e discriminazioni. Il popolo kurdo merita un riconoscimento reale e l’interrompersi dell’atroce e infinito susseguirsi di violenze, un genocidio che attraverso gli anni è proseguito con la connivenza dell’Occidente.
E l’approccio con il contesto di arrivo?
Nonostante i numerosi viaggi e missioni in alcune aree del mondo, sono fermamente convinta che non si conosca mai abbastanza una cultura, quindi considero sempre “sacro” l’approccio da avere, e fondamentale la capacità di adattarsi al contesto in cui si arriva.
Negli anni purtroppo ho assistito a molte azioni di cooperazione che hanno avuto esiti negativi, poiché quando non si pone attenzione alla partecipazione comunitaria, anche i progetti pensati con le migliori intenzioni possono innescare conflitti, corruzione e discriminazione. Quando si lavora in campo umanitario è necessario studiare continuamente, essere autocritici, flessibili e pronti a comprendere nuove e diverse situazioni, impegnarsi e rispettare il territorio con profonda umiltà. Ci vuole apertura alla conoscenza, al dialogo continuo e costruttivo. Nelle missioni amo vivere le situazioni appieno, stare con le persone e ascoltarle: ad animarmi, sempre, è il principio inviolabile dei diritti umani.
Andare in un luogo con lo scettro di chi sa tutto o di chi ritiene di essere comunque dalla parte “giusta” è come dar vita a un nuovo e dannosissimo colonialismo. Bisogna scoprire la quotidianità, porre attenzione a ciò che non è immediatamente visibile, lavorare per l’ottenimento di una pace condivisa, una distribuzione più equa di ricchezze e risorse, uno sviluppo sostenibile, pari opportunità di genere e istruzione, attraverso la lotta contro le crescenti diseguaglianze tra i Nord e i Sud del pianeta.
Avere la fortuna di nascere in democrazia e in libertà non ci deve conferire l’arroganza di esportare il nostro modello, dobbiamo invece impegnarci nella diffusione della pace fungendo da ponti.
Il mio privilegio di uscire di casa senza paura, di poter andare a scuola senza che qualcuno faccia esplodere l’auto sulla quale sto viaggiando, di non subire discriminazioni etniche e di genere… Ecco, questo è quello che vorrei esportare. Vorrei lenire la paura, il terrore, il timore del domani.
Il viaggio e il movimento ai tempi della pandemia.
Non ho sofferto per la limitazione della mia libertà individuale. Personalmente, ne faccio una questione di rispetto: non posso permettermi di lamentarmi. Nelle zone di conflitto le prime cose che vengono distrutte sono gli ospedali e le vie di comunicazione, per noi qui ha funzionato tutto, non è corretto paragonare la pandemia a un contesto di guerra. È un’emergenza sanitaria, da risolvere dal punto di vista politico in senso ampio, partecipato.
Io ho sofferto non per me, ma perché non ho potuto muovermi per realizzare i progetti di gestione delle varie emergenze nel mondo, che avrebbero migliorato o salvato la vita di qualcuno, e forse, con le dovute precauzioni, almeno per queste tematiche, qualche apertura in più poteva esserci. Penso al traffico di esseri umani, aumentato esponenzialmente dall’inizio della pandemia. Il dolore che ho provato è stato per l’impossibilità di partire, di sostenere sul campo chi ne aveva estrema necessità.
E viaggiando nel futuro dell’umanità, idealmente e concretamente?
Bisogna pensare al futuro a livello globale, lavorando per la tutela della pace nel pieno rispetto dei diritti umani, dei principi democratici, contro le disparità di genere e con massima attenzione alla questione migratoria.
È poi fondamentale una progettualità sul medio-lungo periodo, trovando nuove strade, nuovi metodi di lavoro, basata sullo sviluppo sostenibile, in una visione strategica di collaborazione e solidarietà, atta a unire, superare le disuguaglianze, affrontare il paradosso della globalizzazione che crea ricchezza concentrandola in poche mani senza redistribuzione, con una crescente e conseguente marginalizzazione ed esclusione.
Personalmente auspico di proseguire con tenacia nel mio lavoro, attraverso progetti di sviluppo ideati come strumenti con cui incentivare la promozione dei diritti di gruppi vulnerabili e svantaggiati, rimanendo sempre coerente con quella ragazzina che 20 anni fa ha deciso di intraprendere questo cammino.