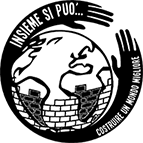La storia di Chiara, ostetrica per sei mesi in Kenya
Quando si parla di esperienze formative utili a universitari o neolaureati spesso si cade nell’errore di considerare come unico ambito privilegiato quello degli stage, dimenticando invece l’universo del volontariato e le infinite opportunità che esso è in grado di offrire.
Ci troviamo ovviamente nella dimensione della gratuità: le attività di volontariato per definizione non prevedono alcuna retribuzione ma questo non esclude che esse possano essere fonte di arricchimento personale e professionale. In un periodo in cui è diventato estremamente difficile trovare un lavoro e ancor di più un lavoro coerente con il proprio percorso universitario, il mondo del volontariato è sicuramente una risorsa non trascurabile.
Ce lo dimostra l’esperienza di Chiara, laureata in Ostetricia nel mese di Novembre e tornata da pochi mesi da un periodo di volontariato presso una struttura sanitaria del villaggio keniota di Tabaka a 300 chilometri da Nairobi.
Come lei stessa ci racconta, trovare un lavoro in Italia come ostetrica non è affatto cosa semplice: i concorsi sono pochi e molti invece sono i concorrenti. Questa difficoltà unita al desiderio, maturato negli anni, di conoscere e vivere l’Africa potendo rendersi utile, l’hanno spinta a cercare una destinazione proprio là, nella “Terra di Nessuno”.
“Ho sempre avuto l’idea di partire per l’Africa. Il solo pensiero di vedere un’altra realtà, di aiutare per quanto possibile persone che realmente hanno bisogno, di essere parte integrante di una struttura ospedaliera con il personale del posto e soprattutto la possibilità di fare l’ostetrica lì è stata per me la realizzazione di un sogno fantastico. Fare il lavoro che ti piace nell’ambiente perfetto e con persone con cui vai d’accordo è una cosa indescrivibile, e, parliamoci chiaro, lì è impossibile non andare d’accordo…”
Il giorno 7 settembre 2015 sono partita come ostetrica per un’avventura in Kenya, e più nello specifico, per Tabaka. Dopo 2 anni a Winchester (UK) tra bambini, volontariato in ospedale, corsi vari e lavoro al bar, volevo realizzare questo sogno.
Partii da sola, dopo aver contattato un ospedale del posto che mi avrebbe accolto “a braccia aperte”, prenotando il volo da un giorno all’altro per la “gioia” dei miei famigliari… Una valigia e uno zaino, dopo 12 ore di volo mi sono trovata all’aeroporto di Nairobi nell’attesa che qualcuno mi venisse a prendere. Dopo essere atterrata e resami conto che non c’era nessuno ad accogliermi ho pensato che si fossero dimenticati di me..
Con un po’ di ritardo un frate si è presentato con un cartello indicante il mio nome: mi sono sentita subito meglio e ho abbandonato l’idea di dormire per le strade di Nairobi. Ma solo nel corso della mia esperienza ho scoperto che il tempo per gli Africani scorre con molta lentezza…
Lentezza: nel vocabolario è sinonimo di svogliatezza, indolenza, apatia ed è proprio quello che pensiamo degli africani attribuendo loro il profilo di persona stanca, pigra. Ma quest’immagine non viene da un confronto con i ritmi vitali; piuttosto da un paragone con le andature super-accelerate che ci contraddistinguono e a cui siamo assuefatti. In Africa vi è un attraversamento lento dell’esperienza, un rallentamento che ti fa avvicinare alla vita e ti fa scoprire le sue latitudini e profondità.
Il rispetto del tempo e dei tempi della vita diviene, allora, compito imprescindibile di ogni comunità educante, capace di scorgere nella lentezza non uno scarto improduttivo, ma un valore aggiunto, fecondo di nuove possibilità.
Brother Joseph, il frate che mi ha accolta in terra africana e accompagnato a Tabaka, era l’amministratore dell’ospedale gestito da padri e frati camilliani, quindi da missionari, che dedicano la loro vita alla cura del malato e del bisognoso. La strada per arrivare al villaggio è stata la più lunga della mia vita, tra la savana, i Masaai, i villaggi sperduti nel nulla, la desolazione e il traffico per uscire da Nairobi. Una natura di grande bellezza caratterizzata da numerosi ecosistemi, dalla savana arbustiva alla foresta pluviale.
Più mi allontanavo dalla città – dove la popolazione bianca, costituita per lo più da inglesi, è in netta maggioranza – più mi sentivo osservata per il colore delle mia pelle. Un’ultima frontiera, retaggio di un’Africa antica che offre un mosaico etnico unico al mondo, abitanti di queste aree in un equilibrio sottile che si evidenzia nei tanti affascinanti mercati della regione, vero tesoro culturale dell’Africa Nera.
Arrivata a Tabaka, rimasi stupita dalla povertà del villaggio, che ho scoperto meglio distribuendo i vaccini contro la poliomielite a tutti i bimbi sotto i 2 anni di età. Devo ammettere che la mia aspettativa più grande era quella di fare l’ostetrica 24 ore su 24, reperibile in ogni momento e in ogni situazione, di affrontare situazioni di duro stress e coltivare la vera arte ostetricia che ormai da noi si sta un po’ perdendo. La paura più grande, era quella di non essere all’altezza della situazione e delle emergenze che sarebbero potute capitare.
Dentro le mura dell’ospedale avevamo la fortuna di avere acqua corrente e bevibile, ma al di fuori, questa possibilità non c’era. In sala parto c’era un boiler che scaldava l’acqua: era l’unico disponibile nell’intero ospedale perché era necessario per fare i bagnetti ai neonati e permettere alle mamme che avevano appena partorito di lavarsi.
Ho svolto turni diurni e notturni, alle volte insieme. Ho assistito donne africane di cultura diversa, durante il travaglio: dalle donne del Kisii che durante il travaglio esprimono il dolore urlando e invocando Dio, alle donne Masaai che soffrono in silenzio e non esprimono alcun tipo di emozione perché vista come manifestazione di debolezza.
Vi è un ricordo indelebile in me del giorno in cui ho assistito nel travaglio una donna, alla sua quinta gravidanza. Dalle precedenti quattro, erano nate tutte bambine. Quindi, assistendola nel travaglio io e le altre volontarie nutrivamo la curiosità di conoscere il sesso del nascituro, soprattutto perché la futura mamma sperava ardentemente in un maschio. Il parto della gravidanza precedente l’aveva fatto in casa dando vita a una bimba di 5.5 kg di peso.
Dopo 5 ore di travaglio, anche questa volta nacque una bimba. Non ricordo di avere mai percepito tanta delusione negli occhi di un padre. Solo dopo, una delle infermiere che aveva collaborato al parto mi spiegò il motivo di tanta amarezza: il marito avrebbe dovuto cercare un’altra moglie con cui avere eredi maschi.
Un ulteriore motivo di stupore fu l’apprendere come le pazienti partorenti con taglio cesareo, non venissero mai aiutate dal marito – come succederebbe da noi – nella cura del neonato; no, una donna della famiglia o una ragazza scelta come “aiutante” sosteneva la neo mamma in tutto il puerperio. Il marito raramente era presente.
Da piccola Colibrì ho sempre nutrito il desiderio di aiutare i bambini africani che nel gruppo ci facevano conoscere. Camminare per le vie della Parrocchia d’inverno perché quel bambino non aveva nulla, era un po’ la missione che mi sono sempre portata nel cuore. E così, durante la mia esperienza sono venuta a conoscenza di una famiglia costituita da i genitori e i loro 4 bambini, abitanti di una capanna, senza mobilio, senza letti ne cucina, senza abiti ,..insomma senza nulla! I bambini non frequentano la scuola, e si accudiscono l’un con l’altro.
Il Progetto Una famiglia dimenticata grazie all’aiuto dei Insieme si può, è una missione che ho a cuore, proprio per dare un futuro a questi bambini e a questa famiglia dimenticata da tutti.
Quando si parte per l’Africa molto spesso si ha l’idea di aiutare e di insegnare qualcosa che magari la gente del posto non conosce. Ecco, non è assolutamente così. L’Africa ti arricchisce: è lei che ti insegna, è lei con la sua gente che ti dà qualcosa che tu non potrai mai dare a nessuno. Sinceramente dopo poche settimane in quel posto meraviglioso io mi sono sentita ricca, non solo perché ho imparato cose che non avrei mai immaginato di imparare professionalmente, ma soprattutto per la ricchezza mentale che ti regala l’apprendere da un modo di pensare diverso. La gente qui da noi non si rende conto di quanto valga un sorriso o un abbraccio. Magari è scontato ma sono i bambini, sono loro il fulcro della società! Io vedo in loro quelli che cambieranno il mondo: hanno grandi furbizia e abilità e, soprattutto, sorridono, giocano con qualsiasi cosa e non perdono mai il sorriso, nemmeno quando sono malati e in fin di vita.
La terra verde, i suoi frutti, i suoi profumi, la sua gente e i suoi bambini continuano e continueranno a essere una viva parte di me. Tornerò presto in quella terra che dà tante emozioni ma, allo stesso tempo, crea un vuoto interiore incolmabile.
Chiara Damerini